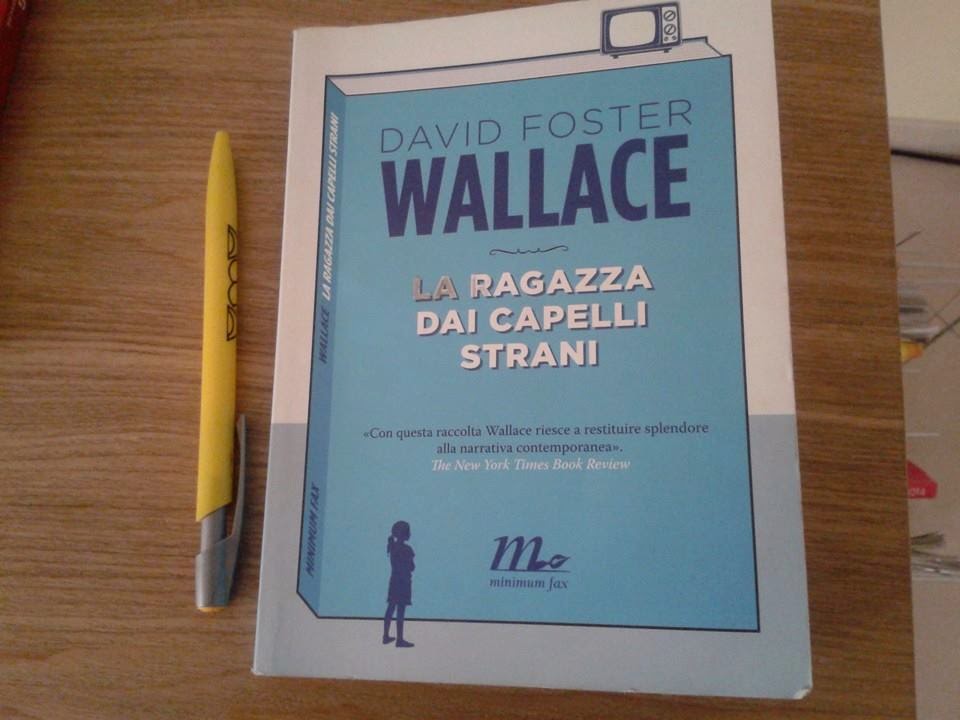|
| Edizione Bompiani |
Che un romanzo riuscisse a spaventare, annoiare e divertire al
tempo stesso non l’avrei ritenuto possibile.
Il pendolo di Foucault lo fa. E
credo che Umberto Eco abbia messo in conto tutto. La suspense, l’intrigo, il mistero, l’ironia, la parodia, il
sarcasmo. E non ultimo la noia, quella che viene dalle lungaggini dottrinali,
da una meticolosa ricerca di documenti, di falsi, di erudite pedanterie
sapienziali che, parodia o meno, il lettore deve sorbirsi e di cui NON PUÒ fare
a meno, se vuole godere del senso profondo di questo romanzo.
Non so dire esattamente quanto tempo ci abbia impiegato a
leggerlo: lo associo all’inverno, a interminabili viaggi in treno fra paesaggi
nebbiosi e ritardi cronici, a serate solitarie trascorse sotto una
stratificazione maldestra di coperte.
Ho divorato pile di libri piacevoli, di cui ricordo a grandi
linee solo la trama, li ho consumati in fretta, in pochi giorni con l’avidità
compulsiva di chi è già proiettato all’acquisto successivo.
Il pendolo di Foucault non appartiene a questa categoria.
680 pagine, caratteri di stampa pro-miopia, un apparato
dottrinale che non potevo espungere senza compromettere il senso del testo, un
lessico, talvolta ricercatissimo, che richiedeva sovente l’“aiutino” del
dizionario, una continua, faticosa, dispersione della narrazione in mille
rivoli. Per terminarlo è occorsa pazienza. Quando sono giunta alla fine,
all’ultimo punto e a capo, a quello definitivo, l’impresa mi è parsa eroica, ma
la lettura non è passata invano. Non è di quelle che scivolano. Non è un
sorbetto al limone tra un piatto forte di pesce e uno di carne. Qui siamo di
fronte a un arrosto esagerato, come dire… trimalchionico!
Il secondo romanzo di Eco
mi ha
lasciato in eredità riflessioni, domande, amarezze, ma soprattutto il desiderio
di una continuazione, bisogno che, in corso d’opera, avrei ritenuto improbabile.
Dopo aver atteso la fine del romanzo con impazienza, mi sono
ritrovata a rimpiangere una scrittura che non indulge a semplificazioni e sciatterie;
una narrazione abbondante, lutulenta, invischiante, che difficilmente avrei
ritrovato in altri autori; una narrazione caustica contro le velleità
artistiche, le ingenuità imperdonabili e i narcisismi che si riconoscono nei
personaggi del romanzo, e in gran parte di noi lettori. Me compresa.
Incipit
“Fu allora che vidi il Pendolo.
La sfera, mobile all’estremità di un lungo filo fissato alla volta del
coro, descriveva le sue ampie oscillazioni con isocrona maestà.
Io sapevo – ma chiunque avrebbe dovuto avvertire nell’incanto di quel
placido respiro – che il periodo era regolato dal rapporto tra la radice
quadrata della lunghezza del filo e quel numero π che, irrazionale alle menti
sublunari, per divina ragione lega necessariamente la circonferenza al diametro
di tutti i cerchi possibili – così che il tempo di quel vagare di una sfera
dall’uno all’altro polo era effetto di una arcana cospirazione tra le più
intemporali delle misure, l’unità del punto di sospensione, la dualità di una
astratta dimensione, la natura ternaria di π, il tetragono segreto della
radice, la perfezione del cerchio”
Infeltrita
Nell’unico respiro con cui si legge questo incipit, il Pendolo si mostra già con
prepotenza come simbolo di una “arcana cospirazione” che travalica i confini
temporali e si perpetua nella storia, generazione dopo generazione sotto tanti
nomi.
Il lettore si trova di fronte a dieci parti, a loro volta
suddivise in numerosi sottocapitoli. Il numero dieci, ovviamente non casuale, ci
riporta ai Sephirot della Cabala ebraica, i mezzi attraverso cui si rivela
l’Eterno. Parti e capitoli sono scanditi da citazioni puntualissime che, in
epigrafe, ripercorrono una sterminata bibliografia esoterica, mistica, magica,
alchemica di ogni tempo. Un contrassegno di erudizione che ci confonde
volutamente, ma a cui ci si deve abituare perché, in varie forme, caratterizza
tutta l’opera. Un tuffo nel filone magico che la cultura occidentale, da
sempre, si premura di tenere a margine, se non di occultare del tutto.
La struttura narrativa è labirintica, come una ricerca
condotta in uno smisurato archivio, senza indicazioni precise. Una ricerca in
cui tutto sembra importante e tutto ci allontana dal punto di partenza e da
quello di arrivo. Il tempo è lento. Lo spazio disorganico, prevalentemente
chiuso.
 |
| Rappresentazione dei Sephirot secondo la Cabala ebraica |
Il romanzo prende le mosse dal Conservatoire des Art set Métiers di Parigi dove è conservato un
esemplare del pendolo di Foucault e dove Casaubon, protagonista e narratore, si
nasconde per assistere alla riunione dei Signori della Convenzione, che si
terrà oltre l’ora di chiusura del museo. La tensione è subito alta. L’attesa
massacrante. I Signori, qualunque cosa rappresentino, saranno pericolosi,
ammantati di segretezza, decisi a portare a compimento il Piano, il Complotto
Universale che muove da epoche lontane e, per vie sotterranee, si perpetua
secolo dopo secolo, catturando la credulità, il bisogno di mistero, di
esoterismo, di irrazionale che alberga nella gran parte degli uomini.
Tre intellettuali, Casaubon, Belbo e Diotallevi, con la
complicità di una casa editrice spregiudicata, decidono, per divertimento, di
gabbare quanti mostrano di credere alla Teoria del Complotto e, recuperando
l’intera letteratura mistica, esoterica, occulta, iniziano a mescolare le carte,
a creare messaggi in codice e segni, a ordire, a tavolino, un Piano che funga
da esca per portare allo scoperto massoni, settari, individui sinistri che
trascorrono la vita (agiata e oziosa) a riesumare antiche tradizioni
diaboliche. Il gioco, però, si fa serio. Sembra sfuggire di mano. Perché c’è
sempre qualcuno pronto a credere al piano e a servirsene per esercitare potere
sugli altri. E gli stessi intellettuali sembrano a un certo punto diventare
vittime della loro stessa cospirazione.
Il lettore, insieme ai tre personaggi principali resterà
sospeso a mezza strada tra l’ironia più tagliente nei confronti
dell’irrazionalismo, che mina di superstizione persino i settori più
insospettabili della scienza, la parodia nei confronti di quella paraletteratura
nutrita di templari, segreti, codici, misteri, intrighi inverosimili,
l’esercizio di una scanzonata goliardia (di cui anche il lettore è vittima) e
un oscuro senso di minaccia costante, di pericolo incombente, imprecisato.
E se il Complotto, sbeffeggiato e deriso, esistesse davvero?
E se il segreto dei templari, catari, RosaCroce, gesuiti, anziani, illuminati e
diosacosa esistesse davvero?
La corsa verso le pagine finali vede la riduzione della
componente parodica e il crescendo di esperienze soprannaturali e inspiegabili.
E se l’irrazionalità trionfa, allora quale messaggio vuole
inviarci l’autore?
La sua è o non è una presa di posizione contro
l’irrazionalità e il misticismo superstizioso?
“Da quando gli uomini non credono più in Dio, non è che non
credano più a nulla, credono a tutto”
Zoom
Mi hanno colpito considerazioni sparse qui e là che,
profeticamente, precorrono i tempi e abbracciano la nostra realtà contemporanea.
§
Il romanzo è stato pubblicato nel 1988, i
Personal Computer cominciavano, molto lentamente la loro ascesa e un programma
di videoscrittura, come può essere il per noi arcinoto Word di Office o
qualunque altro suo corrispondente, suscitava nell’autore perplessità condivisibili
e un certo sarcasmo. Al punto da attribuirgli il nome di Abulafia, una parola
che ha in sé l’abulia (il calcolatore è ottuso) ma anche for-faris parlare. Parlare a vanvera. Il personaggio di Belbo
affida i suoi ricordi ad Abulafia, perché schermato dalla segretezza di una
password si sente protetto da sguardi indiscreti; perché digitare parole sulla
tastiera lo fa sentire meno a disagio che impugnando una penna. Belbo è infatti
uno scrittore mancato, diciamo pure autocensuratosi. Abituato, da studioso fine
qual è, ad avere a che fare con i Grandi sa di non esser degno di pubblicare
qualcosa di proprio. Saggiamente (e pavidamente) non si sottopone
all’umiliazione del giudizio altrui. Ma la voglia di scrivere è forte e il
calcolatore, neonato, glielo consente impunemente. Peccato, che la segretezza
della password (da Eco in tempi a-digitali chiamata il password, cioè il lasciapassare) venga beffata subito da
Casoubon che la decripta e sbandiera tutte le velleità letterarie represse
dell’amico Belbo, non senza punte di cattiveria. Abualfia come antenato del
selfpublishing, come sdoganamento della scrittura, che ne pensate?
§
Se Belbo è uno scrittore castrato, tanti sono
invece gli scrittori vanesii, in preda a un ingenuo narcisismo che li getta
nelle fauci della Manuzio, tipico esempio di editoria a pagamento, “con
fatturato altissimo e spese di gestione nulle”. Sue vittime sono gli APS. Gli
Autori a Proprie Spese. Le pagine, puntualissime e minuziose, dedicate alla
descrizione del funzionamento di queste “imprese della vanità” hanno fatto
storia. E sono gustosissime e cattivelle. Ma servono ancora, perché il
messaggio non a tutti è chiaro.
§
La trama, che percorre i binari della parodia,
parte dai templari. Perché la letteratura fatta di intrecci improbabili,
complicatissimi, di coincidenze e di enigmi parte sempre da loro. Nel 1988
ancora non si era manifestato il fenomeno Codice Da Vinci, ma state certi che
dovunque si raccontasse di templari, comunque si ricorreva ad arcane
cospirazioni, segreti e misteri. E da qualche parte c’era qualcuno pronto a
crederci. C’è sempre qualcuno pronto a crederci. A superare le barriere della
letteratura(?) per mettersi alla ricerca di segni. Di questa storia parallela,
misteriosa, pasticciata, contraffatta, estremamente ingenua Umberto Eco si fa
beffe.
E il lettore, che si identifica troppo, che troppo si lascia
coinvolgere da questo romanzo, ne vien fuori malconcio…